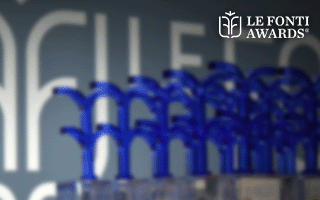Quando si parla di pena da infliggersi dopo la commissione di un reato, l’immaginario collettivo tende ad evocare un castigo. Lo si legge quasi tutti i giorni sui giornali.
L’opinione comune vuole che l’autore di un illecito penale sia punito con una pena dura, afflittiva che si trasformi in sofferenza per l’autore del reato.
Il crimine deve essere perseguito e il criminale perseguitato. Perseguitato anche durante il periodo in cui esso si trova rinchiuso tra le quattro mura di una cella. È una concezione antica questa ma che è difficile da sradicare. Periodicamente, anche per ragioni di parte politica, riemerge forse la più ripugnante tra tutte le manifestazioni dell’animo umano.
Il desiderio di vendetta. Le derive in questa direzione sono oggi più che mai evidenti. Certo lo scopo della pena muta con il mutare della concezione della società e dello Stato secondo il naturale corso della storia. Sarebbe tuttavia buona cosa tenere a debita distanza quei modelli che si ispirano alla necessità di fornire soddisfazione alle pretese private.
Il nostro sistema penale, nonostante l’intensa e positiva evoluzione in senso costituzionalmente orientato, ha ancora le radici ben salde nell’impianto originario del 1930 che per ragioni collegate all’ideologia fascista enfatizzava la lotta alla criminalità. In realtà la legislazione penalistica di quell’epoca era ispirata dalla necessità della classe di governo di ricercare un complesso di difesa ad una serie di forze e fenomeni che potevano mettere in crisi l’assetto stesso della società. Vi era infatti un movimento operaio in forte crescita che riusciva ad aggregare strati della piccola borghesia, intellettuali ed altri protagonisti che andavano in qualche modo contenuti a vantaggio della classe dirigente.
Queste concezioni fecero sì che all’epoca si optasse per un sistema che corresse su un doppio binario cioè un sistema che prevedeva, oltre la tradizionale pena comminata dopo la commissione del reato, una sorta di pena inflitta prima della commissione del reato: la misura di sicurezza, fondata sulla pericolosità sociale del potenziale reo.
Su questo originario impianto, dopo la guerra, si innesta il dettato costituzionale che, ispirato da nuove idee, afferma il principio che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha inteso dare al concetto di rieducazione espresso dalla carta costituzionale il significato di risocializzazione ovvero di reinserimento nel tessuto sociale del soggetto che si era reso responsabile della violazione di un precetto penale.
È chiaro che il concetto di pena come retribuzione, come castigo per il condannato è estraneo al volere del legislatore costituzionale.
Tuttavia, ancora oggi, l’idea di risocializzazione passa attraverso la separazione dell’individuo dal contesto sociale nel quale dovrebbe essere reinserito con la reclusione dello stesso in istituto. Ciò anche in forza di alcuni “automatismi” che dovrebbero, a parere di chi scrive, essere espunti dal sistema. A titolo di esempio si pensi alle previsioni legislative che impediscono la sospensione dell’esecuzione di pene detentive, anche brevi, e il conseguente ingresso in istituto per un discreto numero di delitti. Ingresso che avviene a volte a distanza di anni dai fatti per cui vi è condanna.
Oggi, anche per il venir meno della prescrizione dopo il primo grado di giudizio, può accadere che una condanna che comporta la detenzione “obbligatoria” debba essere seguita dopo un lasso di tempo così importante che il soggetto potrebbe ormai aver cambiato vita in autonomia, potrebbe aver trovato lavoro, messo al mondo dei figli ma, per l’inerzia del sistema, ecco che arriva un ordine di esecuzione non sospeso e la conseguente carcerazione. L’impatto può essere dirompente.
Può succedere che l’esecuzione di una pena arrivi dopo un tempo così lungo da vanificare proprio lo scopo stesso della sanzione tramutandosi in uno sradicamento dalle relazioni con altre persone, con la famiglia e la potenziale perdita del lavoro. In poche parole, se da un lato la funzione di reinserimento sociale fatica ancora oggi ad essere attuata con concretezza dall’altro anche il principio di umanità cui la pena dovrebbe essere ispirata subisce una compressione di non scarsa portata.
Ed ecco che nelle carceri italiane i detenuti continuano a togliersi la vita. Il tasso di “atti anti conservativi” (così vengono chiamati i suicidi nel gergo delle carceri) è diciannove volte superiore rispetto alle persone libere. Le statistiche riportano asetticamente i dati: 59 morti per il 2022 (al 10 settembre fonte ristretti.it), 57 nel 2021, 61 nel 2020 e così via per una media negli ultimi 20 anni di circa 50 suicidi all’anno.
Certo le cause di queste morti sono tante, non ultime le modalità con cui la pena viene scontata. I luoghi di detenzione sono spesso obsoleti, tristi, con un’architettura “cupa” che intristisce anche solo a rimanervi per qualche ora. Il carcere è un luogo dimenticato. Gli istituti sono sovraffollati, mancano gli operatori, mancano i medici.
È solo grazie agli sforzi di chi dirige e organizza questi luoghi che si è potuto realizzare, anche in strutture cadenti e affollate (ad esempio la casa circondariale di San Vittore) spazi per attivare laboratori e corsi di formazione; ambienti per la socialità, cortili trasformati in luoghi dove praticare sport all’aria aperta.
Indagare su queste morti è molto complesso, ma alcune indicazioni vengono da un ampio studio condotto da un’associazione che si occupa dei diritti dei detenuti (ristretti orizzonti) che individua quale “comun denominatore” dei suicidi la mancanza totale di prospettive. Infatti chi attende il processo, a volte per mesi se non per anni, si ritrova di fronte alla perdita di speranza di riottenere la rispettabilità perduta, perché per varie ragioni il sospetto è marchio indelebile che difficilmente viene rimosso anche da una sentenza assolutoria.
Nessuna prospettiva ha davanti anche chi è in fase di esecuzione perché in tante carceri il tempo della pena è tempo vuoto, dissipato lentamente nell’attesa del fine pena che è un traguardo spesso posto ad anni di distanza.
La mancanza di prospettiva di poter tornare a vivere una vita normale e un futuro fatto di una vita ai margini, di solitudine, di sofferenza fisica e psicologica sono gli elementi che danno origine ai gesti estremi. A fianco dei suicidi vi sono anche i tentativi. Su questo fronte è più complesso individuare dati anche perché il detenuto che tenta il suicidio è etichettato come deviante in quanto compie un atto di insubordinazione. L’aspirante suicida è considerato come una persona che ha sviluppato una patologia psichica e come tale viene trattato ovvero con un trattamento di tipo sanitario.
Non è questo certo il luogo per individuare possibili soluzioni, basti però ricordare che forse la via intrapresa di recente, che vuole l’ampliamento delle modalità alternative per scontare la pena, è strada da essere sempre più valorizzata.
Di Alessandro Bastianello, Avvocato, Coordinatore della Sottocommissione Carcere dell’Ordine degli avvocati di Milano