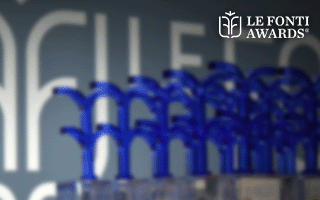Sebbene l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione e una cultura di “subordinazione” abbiano complicato il lavoro agile nel lockdown, i suoi benefici su welfare e costi aziendali hanno convinto molte imprese ad applicarlo anche nel post emergenza. A patto che venga ben regolamentato e reso più flessibile
Nel 2019, stando alle stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, erano circa 570.000 i lavoratori che avevano accesso allo smart working. La diffusione dello strumento aveva riguardato il 58% delle grandi imprese (Eni ha iniziato a sperimentarlo già nel 2017), molto meno la pubblica amministrazione (16%) e le pmi (12%). Con l’arrivo del Covid il lavoro agile è divenuta l’unica forma possibile di esecuzione della prestazione, anche per chi non era pronto: secondo i dati del rapporto Istat sulla situazione e le prospettive del Paese, nel periodo emergenziale il 90% delle grandi aziende (250 addetti e oltre) e il 73,1% delle imprese di media dimensione (50-249 addetti), hanno introdotto o esteso lo smart working, mentre tra le aziende minori ne hanno fatto ricorso il 37,2% delle piccole imprese (10-49 addetti) e il 18,3% delle microimprese (3-9 addetti). Il lockdown, quindi, ha obbligato tutti indistintamente a confrontarsi con questa nuova modalità di lavoro da remoto che, se da un lato ha favorito il benessere dei dipendenti, migliorato l’equilibrio tra impiego e vita privata e ridotto i costi aziendali, dall’altro ha fatto emergere tutte le complessità e i limiti legati alla gestione delle aziende nel nostro Paese. Stando a quanto riferito dagli avvocati interpellati da Le Fonti Legal, le principali criticità riscontrate dai loro clienti nell’applicazione dello smart working durante il blocco hanno riguardato la carenza di strumenti adeguati per operare e interagire da remoto, il limitato, o assente, accesso alle risorse aziendali, la perdita di contatto con i colleghi e con i clienti, ma soprattutto la presenza di una cultura aziendale ancora troppo improntata alla subordinazione, perciò ben lontana dalla flessibilità che lo strumento impone. Nonostante ciò, per molte imprese il lavoro agile diventerà strutturale anche dopo la fine dello stato di emergenza. Affinchè, però, incida positivamente sul welfare e aumenti la produttività, imprenditori e avvocati ne chiedono una regolamentazione precisa che definisca l’architettura dei contratti. Per i consulenti legali, inoltre, sarà fondamentale creare una nuova cultura organizzativa orientata a obiettivi e risultati e basata su una reciproca fiducia tra datore e dipendente.
Lavoro agile, limiti e criticità
Secondo Angelo Zambelli, co-managing partner di Grimaldi Studio Legale, il lockdown e la “remotizzazione” di massa di milioni di lavoratori privati e pubblici che ne è seguita, hanno messo in luce le criticità derivanti dallo scarso affidamento che, sino ad ora, si era fatto sullo smart working: «La Legge 81/2017, introducendo la disciplina del “lavoro agile”, aveva infatti cercato di rispondere alle esigenze di maggiore flessibilità e di miglior bilanciamento tra vita personale e attività lavorativa, prevedendo che un accordo scritto tra datore e il singolo lavoratore ne disciplinasse in dettaglio le modalità esplicative. All’arrivo dell’emergenza epidemiologica», prosegue Zambelli, «la cultura aziendale nel nostro Paese era tuttavia molto poco flessibile, ancora improntata ai noti schemi della subordinazione, e come tale impreparata alla enorme trasformazione dell’organizzazione aziendale che lo smart working presuppone ed impone. Il risultato cui si è giunti a causa della decretazione d’urgenza è stata quindi una forma “distorta” di lavoro agile, più in linea con la definizione atecnica di “home working”. Infatti, se la normativa ordinaria presupponeva una trasformazione del rapporto fiduciario tra datore e lavoratore, frutto di uno specifico accordo individuale, la normativa emergenziale ha condotto ad uno smart working unilateralmente imposto dalle aziende in assenza di un reale mutamento organizzativo oltre che culturale, così sollevando molteplici dubbi e criticità. L’organizzazione aziendale, infatti, è sostanzialmente rimasta uguale a sé stessa, pur a fronte di esigenze di necessaria flessibilità». A detta di Zambelli i problemi che ne sono derivati hanno riguardato la quantificazione del lavoro straordinario a causa della discrasia tra un’organizzazione aziendale ancora focalizzata sulla prestazione legata alla presenza in ufficio (ed al rispetto di un rigido orario di lavoro) ed il mutato contesto culturale ed economico, incline ad una prestazione basata sulla performance, con conseguente difficoltà di controllo del datore di lavoro dell’effettivo tempo di lavoro; «in secondo luogo, l’assenza di una disciplina specifica del rapporto ha spesso inciso sulla fornitura degli strumenti idonei a rendere la prestazione lavorativa, il cui onere era senz’altro a carico del datore di lavoro, in virtù dell’unilateralità della decisione, pur se impreparato a tale approvvigionamento. Ulteriori criticità sono emerse in tema di responsabilità circa la salute e sicurezza sul lavoro e di diritto ai buoni pasto, sulla cui doverosità di erogazione durante il lockdown e conseguente permanenza a casa del prestatore si è molto discusso, almeno sino alle ultime pronunce giurisprudenziali che ne hanno escluso la natura retributiva a favore di quella di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, escludendone pertanto la necessaria erogazione ai lavoratori».
Anche Giulietta Bergamaschi, managing partner di Lexellent, fa notare che la situazione di emergenza è stata più assimilabile ad una modalità di lavoro di “crisi” che non allo smart working o lavoro agile così come era inteso fino a prima del lockdown. Secondo Bergamaschi, la situazione di emergenza ha fatto sì che si trovasse un modo che consentisse alle parti di ricorrere al lavoro da remoto nel minor tempo possibile e con ancora minori formalismi «anche in assenza di un accordo individuale, promuovendone cioè il massimo utilizzo in forma semplificata, con l’informativa di sicurezza predisposta da Inail. Le maggiori difficoltà riscontrate dalle aziende sono più che altro in termini organizzativi che non normativi. Sotto il profilo normativo, una cosa molto importante da tenere presente, è la protezione del patrimonio immateriale dell’azienda che transita su sistemi informatici non necessariamente adatti a garantirlo, situazione che va affrontata con apposite policy. Un altro tema fondamentale è legato alle modalità con le quali i lavoratori agili nell’emergenza hanno affrontato la loro attività lavorativa. Alcune aziende, anche quelle già dotate di un regolamento sullo smart working ai sensi della Legge 81 del 2017, hanno ritenuto opportuno dotare i propri dipendenti di un decalogo per i lavoratori agili dell’emergenza che contenesse anche consigli pratici per creare la propria postazione di lavoro in un luogo confortevole sotto tutti i punti di vista, il consiglio di fare brevi pause nel corso della giornata, di rispettare gli orari di lavoro dell’ufficio evitando di prolungare la presenza al computer ed una eccessiva connessione agli strumenti informatici aziendali. Alcune aziende hanno messo a disposizione dei propri dipendenti servizi da remoto che consentissero ai lavoratori di passare piacevoli momenti di distrazione per sostenerli nel periodo di lockdown in cui le persone dovevano rimanere a casa e per evitare che il lavoro agile continuativo si trasformasse in una fonte di stress e hanno inserito questi consigli nel decalogo dei lavoratori agili dell’emergenza».
Roberto Podda, partner di K&L Gates ritiene che le maggiori criticità riscontrate sono relative alla gestione della procedura telematica per la comunicazione dei lavoratori in smart working; alla necessità e opportunità di garantire al dipendente un rimborso delle spese per la connessione internet e per gli strumenti tecnologici; alla necessità e opportunità di pagamento del lavoro straordinario in smart working e alla corrisponsione del buono pasto anche in smart working; alle valutazioni circa l’esistenza di un “diritto” allo smart working.
Paolo de Berardinis, socio fondatore dello Studio Legale de Berardinis Mozzi, ritiene che sono pochissime le aziende riuscite, attraverso accordi collettivi ovvero individuali, a regolare in modo uniforme l’attività dei propri dipendenti resa in smart working: «La conseguenza diretta di tutto ciò è stata la necessità di continui adattamenti in particolare per quanto riguarda la distribuzione dell’attività lavorativa. In altre parole, l’imprescindibile “fai-da-te” ha inciso fortemente su elementi quali la distribuzione dell’attività lavorativa, i tempi di realizzazione, la disconnessione. Tutti temi che obbligatoriamente dovranno essere in futuro oggetto di opportuna regolamentazione, tanto più che successivamente al 15 ottobre prossimo, cessata l’epoca emergenziale, bisognerà concludere specifici accordi, siano essi collettivi ovvero individuali, per regolamentare lo smart working».
Anche Vincenzo Fabrizio Giglio, partner di Lexia Avvocati, sottolinea quanto le imprese non fossero preparate a questa emergenza: «trasferire in remoto le abituali attività d’ufficio presuppone un’infrastruttura tecnologica e organizzativa che non tutti avevano. In questo naturalmente le realtà di minori dimensioni hanno incontrato maggiori difficoltà. I principali problemi sono emersi con riferimento alla disponibilità anzitutto delle infrastrutture (computer e connessione). Altro problema è l’accesso alle risorse aziendali: archivi, modelli, sistemi informativi in molti casi sono cartacei o accessibili solo dalla rete aziendale; altro «salto» importante, tecnicamente più banale, meno ovvio culturalmente, è stato il dotarsi e l’usare gli strumenti di conferenza remota, fino a poco tempo fa misconosciuti dai più. Infine, esteso su tutto, c’è il rilevante problema della banda larga: una connessione inadeguata può da ostacolare o vanificare ogni sforzo di accesso remoto alle risorse».
«Il brusco passaggio al lavoro da remoto», afferma Federico Strada, partner di Dla Piper, «si è scontrato, in primis, con la carenza dei mezzi tecnologici oltre che di istruzioni operative sulla gestione dello smart working. Il tema più delicato che è emerso nel corso del tempo è l’assenza di una moderna visione manageriale da parte di molti dirigenti, tuttora convinti che un dipendente in smart working sia un dipendente in vacanza. Questo ha originato, da un parte, un incremento nello stress delle risorse gestite, dall’altra un vero e proprio rigetto, da parte dei manager, di questa modalità di lavoro».
«A mio avviso», afferma Valentina Pepe, partner di Pepe & Associati «il lavoro agile impone alle imprese, prima di tutto, una scelta culturale e, solo successivamente, organizzativa. Il lavoro agile non può prescindere, nella sua accezione virtuosa, dall’adozione di modelli di lavoro flessibili non solo rispetto agli spazi ma anche rispetto alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Questo non sempre è avvenuto in questi mesi. Molti lavoratori, infatti, hanno continuato ad essere sottoposti ai medesimi vincoli di orario e alle stesse modalità di lavoro e di interazione dell’ufficio, venendo di fatto a modificarsi, esclusivamente, il luogo della prestazione lavorativa. Di fronte a questi casi possiamo più correttamente parlare di telelavoro e non di lavoro agile. Sempre riconnesso al tema della mancata flessibilizzazione della prestazione lavorativa è quello del diritto alla disconnessione: la flessibilità nell’organizzare i tempi della prestazione lavorativa, nell’ambito dei limiti ovviamente individuati dall’azienda, è elemento essenziale rispetto al rischio di sovraccarico lavorativo, cosiddetto “burn-out”, che discende dalla possibilità di essere raggiunti in qualunque momento e in qualunque luogo da informazioni e incombenti lavorativi».
«Nella fase iniziale», spiega Gianluca Crespi, partner di Elexia, «le imprese si sono trovate nella necessità di riorganizzare integralmente le modalità di svolgimento del lavoro da sempre adottate, chiudendo i propri uffici e continuando l’attività produttiva a distanza. Questo ha creato evidenti problemi organizzativi e gestionali legati, innanzitutto, ad assicurare che tutti i dipendenti fossero dotati di adeguati strumenti di lavoro ed in condizione di interagire tra loro. Con il lavoro a distanza, non sono mancati ovviamente casi di dipendenti che, un po’ approfittando della situazione, hanno lavorato meno del solito, né casi di superiori gerarchici che, temendo tali situazioni, hanno pressato i propri team di lavoro talvolta in modo eccessivo. Alla fine del lockdown, invece, si è affrontato il problema inverso, legato al reingresso (parziale o talvolta integrale) dei lavoratori in azienda, con la necessità di riorganizzare gli spazi e i tempi di lavoro, allo scopo di gestire la ripresa dell’attività lavorativa in sicurezza».
A detta di Giorgia Barberis di Lexant i temi più diffusi riguardano la necessità di consegnare informative particolari ai lavoratori, l’esigenza di dotarli di strumenti per lavorare o se possono usare i propri e ancora, in quali casi può essere concesso lo smart working totale o parziale e se lavorare da remoto è un diritto del lavoratore oppure l’azienda ha la facoltà di rifiutarsi di concederlo.
«Il periodo di lockdown», dice Carlo Majer partner di Littler «ha obbligato praticamente tutti i datori di lavoro a confrontarsi con temi rispetto ai quali in molti casi non avevano alcuna dimestichezza. È sicuramente il caso dello smart-working, ma anche quello della gestione del personale che doveva necessariamente rendere la propria prestazione in sede, e quindi il tema dei controlli del corretto adempimento delle prescrizioni previste dai diversi protocolli che si sono succeduti, la gestione delle tematiche in materia di privacy e di controlli sanitari. Per alcuni di tali temi, e penso in particolare allo smart-working, il legislatore ha provveduto ad eliminare, almeno temporaneamente, la maggior parte delle formalità, così favorendo una rapida applicazione/comprensione dell’istituto. Per le altre problematiche evidenziate, purtroppo, non è andato tutto liscio allo stesso modo. La continua sovrapposizione dei provvedimenti emergenziali ha creato molta confusione e incertezza, obbligando i datori di lavoro a dover gestire tali problematiche, tutt’altro che semplici, da un giorno con l’altro».
Chi, invece, non ha riscontrato particolari criticità è Michele Bignami, socio di Nctm: «I nostri clienti non hanno avuto particolari problemi ad adottare schemi di “smart working emergenziale”; abbiamo, anzi, registrato una notevole tempestività nel reagire e nell’organizzarsi anche rispetto a realtà per le quali il passaggio era tutt’altro che scontato».
Anche nell’esperienza di Silvia Tozzoli, partner di Legance, le criticità sono state poche: «Va considerato che la legge 81/2017 era già stata concepita con un coinvolgimento stretto del mondo delle imprese nella definizione dello stesso concetto di lavoro agile e poi della relativa regolamentazione, creando già dall’inizio, con una sorta di unicum non troppo frequente nell’esperienza italiana, uno strumento genuinamente flessibile e vicino ai bisogni del mondo produttivo. A ciò si è aggiunta la intelligente scelta del legislatore dell’emergenza di introdurre regole ancor più semplificate (assenza di accordo) per il ricorso allo strumento. Durante il lockdown è stato quindi possibile ricorrere rapidamente allo smart working e salvare la produttività e continuità aziendale».
«Per quanto riguarda la nostra esperienza», racconta Livio Bossotto, counsel Allen & Overy Italia «i nostri clienti sono in genere società multinazionali o aziende di grandi dimensioni, per le quali avevamo predisposto, già prima dell’emergenza sanitaria, tutto l’apparato legale necessario per regolare l’attività di smart working. Di certo, lo smart working svolto durante il periodo di lockdown ha caratteristiche strutturali in parte diverse da quelle configurate dal legislatore in sede di introduzione di tale modalità di lavoro con legge 81/2017. Ad esempio, a differenza di quanto previsto dalla norma del 2017 che prevede la possibilità di svolgere parte della prestazione in modalità di smart working, durante il periodo di lockdown, la prestazione lavorativa in smart working è stata pressoché esclusiva, rendendo necessaria una deroga alle policy aziendali e agli accordi di smart working già predisposti. Quesiti frequenti e criticità sono poi insorte in relazione agli straordinari, alla sicurezza sul lavoro e, assistendo molte società internazionali, anche con riferimento al caso di smart working eseguito in un paese diverso da quello di residenza, con le tematiche fiscali, contributive e di norme sull’immigrazione che ne conseguono».
La versione integrale dell’articolo sul numero di settembre di Le Fonti Legal