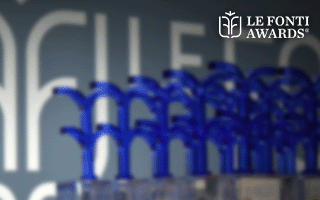Ha tenuto banco, in questo inizio 2020, la lettera del Consiglio distrettuale di disciplina della Corte d’Appello di Milano che annuncia sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati che divulgano i nomi dei clienti sui social e acquisiscono premi e riconoscimenti da soggetti “istituzionalmente non abilitati”.
Si è detto e scritto tanto, e nell’ambito dell’editoria specializzata c’è anche chi ha provato a strumentalizzare la lettera per trarne un vantaggio competitivo. Ma quello che manca, effettivamente, nel panorama dell’informazione di settore sono delle linee guida per i tanti avvocati che intendono puntare sull’attività di marketing personale o di studio, utilizzando qualsivoglia modalità o mezzo, ma che si trovano bloccati dalla missiva del Consiglio di disciplina. Dato che Le Fonti Legal vuole essere prima di tutto una rivista “di servizio” per i professionisti, abbiamo provato, con l’aiuto di esperti, ad addentrarci nei meandri di una lettera che, di fatto, è stata scritta in modo approssimativo, nebuloso, e con una superficialità di fondo rispetto a quella che è oggi la realtà del mondo legale.
Andiamo con ordine. Il Consiglio di disciplina fa riferimento anzitutto all’art. 35, c. 8, del codice deontologico forense, laddove prevede che “nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”. Il riferimento, presumiamo, è ai comunicati stampa degli studi legali dove si dà conto di una data operazione facendo nome dei clienti assistiti. Note stampa che, generalmente, vengono rilanciate e veicolate sui social.
Il tema è vecchio, “andava di moda” ormai quasi 15 anni fa, quando le liberalizzazioni introdotte dal decreto Bersani del 2006 hanno sdoganato l’attività di comunicazione da parte degli avvocati, salvo il divieto di divulgare il nome dei clienti, anche se consenzienti, che è “sopravvissuto” nel vecchio e nel nuovo codice deontologico. Da ultimo, sul tema si è pronunciata la Cassazione (sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017), che da un lato ha confermato la “bontà” del divieto valutando il caso di un professionista che aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti. Dall’altro, la Suprema Corte fa riferimento all’esercizio della giurisdizione “che impone maggiore cautela in materia” e all’attività di carattere “processuale” svolta da parte dell’avvocato nei confronti dei clienti. Manca quindi, a oggi, un precedente sanzionatorio nei confronti di chi condivide le proprie operazioni sui social.
Veniamo ora alla parte dedicata alla “assegnazione di premi qualificanti capacità professionali in singoli campi di operatività”. Secondo il Consiglio di disciplina, si tratta di titoli che “non sono stati oggetto di una valutazione in termini di trasparenza e comunque provengono da soggetti istituzionalmente non abilitati ad una valutazione della nostra capacità professionale”.
Alcuni operatori hanno tentato di strumentalizzare questo aspetto mettendo in mostra presunte capacità di valutazione e trasparenza. Ma qui in gioco c’è ben altro: il riconoscimento istituzionale, che ovviamente nessuna casa editrice o media company possiede.
Questa condotta, da parte degli avvocati, costituirebbe una possibile violazione dell’art. 37 del codice deontologico, che altro non è che il “divieto di accaparramento di clientela”. Il riferimento riteniamo sia in particolare ai commi 1 e 2. Leggiamoli. Il comma 1 prevede che “l’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro”. Dato che gli editori specializzati che corrispondono premi non sono né agenzie né procacciatori d’affari, probabilmente viene messa all’indice l’esibizione, da parte dell’avvocato, di un titolo (esempio: “avvocato dell’anno diritto del lavoro”) che, non essendo corrisposto da un soggetto istituzionalmente qualificato, potrebbe trarre in inganno un potenziale cliente nella scelta del dato studio rispetto ad un altro. Il punto è dimostrare, da parte dell’ordine, che l’incarico è corrisposto all’avvocato X perché ha ottenuto il riconoscimento Y dal soggetto Z. Molto aleatorio.
Anche in questo caso, nella banca dati deontologica del Cnf manca qualsiasi precedente e le sentenze sull’accaparramento di clientela sono tutte lampanti. Il comma 2, invece, recita che “l’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali”.
Stesso discorso: manca la “pistola fumante”. Se il riferimento è agli “awards” degli avvocati, generalmente viene prevista una quota per la partecipazione alla data serata dove possono esserci dei momenti di “networking” professionali. Che tale condotta possa costituire un illecito professionale pare difficile, e la giurisprudenza in questo senso non aiuta.
Insomma, c’è grande confusione. Tanto che l’Ordine di Milano vuole apportare delle modifiche al codice deontologico, operazione tutt’altro che semplice però. Per farlo, è necessario il benestare del Cnf e i tempi sono tutt’altro che brevi.
Nel frattempo, il rischio che corrono gli avvocati, se effettivamente il Cdd passerà dalle parole ai fatti, è di andare incontro a sanzioni che, esaminata la giurisprudenza, non andranno oltre l’avvertimento e che, in caso di ricorso, dovranno essere valutate dal Cnf e, in ultima istanza, dalla Cassazione. Un quadro che, in attesa dei doverosi chiarimenti da parte del Consiglio di disciplina, potrebbe avere come titolo quello di una famosa commedia: “molto rumore per nulla”.