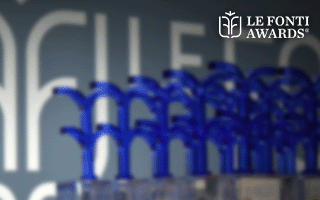Non basta l’emergenza sanitaria. Le imprese devono fare i conti con l’iper produzione legislativa da parte di governo ed enti locali.
Un vero e proprio dedalo: norme su norme che hanno scandito l’attività produttiva delle imprese italiane da inizio marzo a oggi. Poca chiarezza, sovrapposizioni tra autorità nazionale e regioni e un rischio: la tutela della salute dei lavoratori e le responsabilità del datore di lavoro. A ricostruire i giorni concitati dell’emergenza, le criticità affrontate dagli imprenditori e soprattutto i danni che sta facendo l’apparato burocratico è Maddalena Boffoli, avvocato giuslavorista fondatrice dello studio legale Boffoli.
Avvocato, partiamo dalla “Fase 1”: quali gli Impatti sulle imprese e come considera la gestione dell’emergenza da parte del governo?
Come qualcuno ha già evidenziato, il periodo che stiamo vivendo verrà certamente annotato nei libri di storia per l’eccezionalità che lo sta caratterizzando: e tanto, non solo per l’impatto anche psicologico che l’emergenza sanitaria ha avuto e sta avendo sulla popolazione in conseguenza del rapido diffondersi del virus e delle drammatiche conseguenze di mortalità verificatesi, ma anche per gli effetti che si stanno ripercuotendo a livello economico, sociale, istituzionale e scientifico. È indubbio, infatti, che siamo dinanzi ad un fenomeno epidemiologico senza precedenti, che sta notevolmente incidendo, a livello nazionale ed internazionale, anche (e non solo) nel settore economico e produttivo. A fronte, infatti, della diffusione del contagio da Covid 19, l’Italia, come noto, anche prima degli altri paesi (se pur dopo la Cina) si è trovata a dover affrontare improvvisamente una situazione inedita, in un contesto davvero poco chiaro e con molti fattori di incertezza, anche dal punto di vista scientifico. E così, a tutela del bene primario della salute, le misure di contenimento adottate, sino all’imposizione del lockdown nazionale, hanno sensibilmente inciso sulle vite di ciascuno, stravolgendo, con misure senza precedenti, il tessuto economico e sociale del nostro paese. Per chiarire la portata degli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid 19, i risultati di un’indagine effettuata da Confindustria su circa 6.000 imprese italiane (associate e non) appare piuttosto significativa. È emerso che il 67% delle imprese ha registrato impatti sulla propria attività a causa della diffusione del Covid-19 in Italia, soprattutto in Lombardia e Veneto. Il 29% delle aziende consultate già registra danni al proprio fatturato, la percentuale più esigua (6%) ha subito disagi nelle catene di subfornitura e quasi il 22% ha sperimentato problemi di entrambi i tipi. Solo il 33% delle imprese risulta non aver subito danni, circa il 24% ritiene di avere subito impatti gestibili attraverso piccoli aggiustamenti del piano aziendale, il 19% delle imprese ravvede che i danni siano stati significativi perché implicheranno la riorganizzazione del piano aziendale e c’è circa un 12% delle imprese che già teme di non poter raggiungere gli obiettivi per l’anno in corso, se non addirittura di dover ricorrere a ridimensionamenti della struttura aziendale. Come avvocati giuslavoristi, siamo stati ovviamente sollecitati a supportare le società nella difficile gestione di emergenza del settore organizzativo: e infatti, accanto alle aziende che hanno dovuto sospendere la propria attività produttiva e/o commerciale, altre, a garanzia del mantenimento, anche di pubblica utilità, dei servizi richiesti, hanno dovuto in ogni caso adottare misure che tutelassero il bene salute di propri dipendenti, con inevitabili conseguenze, in entrambi i casi, sull’organizzazione di tutto il personale.
Non ha aiutato l’iper-produzione normativa da parte del Governo.
In tutti i casi, le richieste pervenute di consulenza legale nel diritto del lavoro hanno riguardato la gestione e l’organizzazione del lavoro in funzione dei D.P.C.M. di volta in volta adottati, l’adeguamento alle misure necessarie negli ambienti di lavoro e in tema di privacy, nonché la risoluzione di specifiche problematiche nei tempi ristretti imposti dalla situazione di emergenza sanitaria e provvedimenti restrittivi governativi, non sempre di chiara lettura.
In tale situazione emergenziale, pur comprendendo le difficoltà che il governo ha incontrato nel far fronte ad una condizione complessa ed inaspettata, l’intervento normativo ha oggettivamente creato situazioni di indiscussa incertezza interpretativa, che si sarebbe potuta evitare con regole semplici e provenienti da fonti univoche.
Quasi ogni giorno, invece, sono state pubblicate direttive e provvedimenti, non solo dalla Presidenza del Consiglio (i famosi DPCM di Conte), ma anche Ordinanze da parte di Ministeri, Regioni e Comuni, Circolari interpretative, a volte anche in conflitto con i Decreti presidenziali, costringendo le imprese a dover affrontare una situazione di incertezza nell’applicazione delle nuove disposizioni che, peraltro, è bene ricordarlo, devono comunque convivere e coordinarsi con il complesso impianto legislativo preesistente.
Quali criticità può segnalare?
Tra le incertezze interpretative riscontrate tra le aziende che assisto, non può non citarsi quella legata all’individuazione delle attività consentite e quelle, invece, da sospendere, per la determinazione delle quali il Governo ha scelto il criterio del codice Ateco. Anche in questo caso, la produzione normativa è stata frammentaria e poco chiara, essendo intervenuto inizialmente (D.P.C.M. 11 marz 2020) il blocco delle attività commerciali (negozi, bar, ristoranti, ecc.) e quelle di servizi alla persona, poi modificate da Ordinanza del Ministero della Salute (20 marzo 2020). Successivamente, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 è intervenuto sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali potevano essere svolte le attività economiche e, facendo salve le disposizioni già indicate nei precedenti provvedimenti, ha disposto la chiusura delle attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate, per gruppi di attività, tramite i codici ATECO. Ogni tipo di attività, anche quelle sospese, poteva comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile e restavano sempre consentite anche le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività ammesse, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto. Dopo soli tre giorni, il Mise, con decreto 25 marzo 2020, anche a seguito delle segnalazioni di Confindustria e delle associazioni sindacali di categoria, oltre ad aver aggiornato l’elenco delle attività produttive ammesse, ha altresì provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di queste.
L’utilizzo dei codici Ateco ha certamente facilitato l’individuazione delle attività consentite, ma, allo stesso tempo, ha creato non pochi dubbi operativi legati a specifiche situazioni concrete; si pensi, ad esempio, ai molti casi in cui un’impresa svolge attività comprese in più codici Ateco (di alcune escluse e altre incluse tra le attività ammesse), ovvero nell’ipotesi in cui si è fatto riferimento in maniera piuttosto vaga alle imprese produttive rientranti nelle filiere di prodotti e servizi essenziali (trasporti, commercio al dettaglio, ecc). Addirittura, alla pubblicazione dei vari DPCM, non sono mancate richieste da parte di alcune aziende anche solo banalmente per sapere se potevano continuare a svolgere la propria attività o meno e in che misura, dovendo ricorrere molto spesso alle interpretazioni di volta in volta fornite dalle FAQ sul sito del Governo o delle associazioni di categoria (Confindustria), per poi avanzare, di caso in caso, richieste specifiche al prefetto competente. Capitolo a sé è poi quello della cassa integrazione, laddove innanzi ad un’apparente semplificazione normativa e procedurale, stando agli ultimi dati disponibili, solo una regione ha superato il 50% delle domande pagate, mentre ci sono ancora tre regioni al di sotto del 10% dei pagamenti effettuati.
Pare evidente, a mio parere, che, con l’emergenza sanitaria, si stia delineando anche un’emergenza normativa, giuridica e burocratica, che rischia seriamente di rallentare la ripresa economica delle aziende e del paese, essendo, invece, necessari interventi legislativi più semplici ed accessibili alle imprese.
Come diceva, inoltre, ci sono le tante aziende che hanno riconvertito l’attività in produzione di mascherine salvo poi ritrovarsi con il cerino in mano.
Emblematica dell’incertezza creata dagli interventi governativi di volta in volta emessi, è stata proprio la vicenda delle mascherine e, in particolare, dell’iter burocratico previsto per la produzione e commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale (cd. DPI) da parte delle aziende e l’eventuale riconversione della produzione delle stesse. Ho seguito personalmente “l’avventura” di un’azienda di produzione di capi d’alta moda che ha deciso di riconvertire, per la durata dell’emergenza sanitaria, i propri impianti per la produzione di mascherine. Come noto, il D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia) ha previsto, per far fronte alla situazione emergenziale connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine e DPI, limitatamente al periodo dell’emergenza, la possibilità di produrre, importare e immettere in commercio tali prodotti anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Al fine di avvalersi della suddetta deroga, era previsto il rilascio di un’autocertificazione che accertasse che la produzione ed il prodotto fossero conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza. La norma prevedeva, inoltre, che l’Istituto Superiore della Sanità e l’Inail avrebbero avuto l’onere di verificare le autodichiarazioni e fornire il proprio benestare entro 3 giorni dall’acquisizione dell’autocertificazione. Pertanto, la società, nell’incertezza interpretativa sulla differenza tra mascherine chirurgiche e DPI, ha trasmesso la richiesta ad entrambi gli enti. Orbene, a fronte delle richieste inviate, l’Inail ha ritenuto che, sulla base della documentazione pervenuta, il prodotto non rientrasse tra i dispositivi di protezione individuale e, pertanto, non fosse di propria pertinenza, mentre la richiesta di validazione straordinaria delle mascherine chirurgiche inviata all’ISS, non ha ricevuto riscontro nel termine previsto di tre giorni, dovendo intendersi rigettata (silenzio-diniego). A tanto si aggiunga, inoltre, che l’azienda in questione svolgeva attività per le quali era previsto l’obbligo di sospensione e, pertanto, è risultato necessaria un’espressa deroga da parte del Prefetto per lo svolgimento di attività relative a servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, quali, appunto, la produzione di mascherine. Solo dopo avere richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni dai laboratori indicati per l’effettuazione dei test di congruità dei prototipi realizzati, la richiesta è stata, pertanto, reinoltrata all’ISS che finalmente ha concesso l’autorizzazione alla produzione. Anche in questo caso, l’anomalia della norma emanata nell’urgenza, la quale apparentemente prevedeva per produttori e importatori una semplice autocertificazione che dichiarasse la conformità del prodotto agli standard dell’ISS o dell’Inail, in realtà prevedeva per le aziende italiane la preventiva autorizzazione ISS/INAL, così invece favorendo le imprese straniere (cinesi, indiane o brasiliane), che, come abbiamo potuto leggere nelle cronache, hanno potuto esportare nel nostro paese dispositivi, mediante una semplice autocertificazione, che invece non sono poi risultati conformi alle stringenti normative applicate in Italia. E tanto con un evidente doppio danno di carattere economico: il primo, la spesa che lo stato ha dovuto sostenere per l’acquisto di mascherine non utilizzabili, il secondo, la mancata possibilità delle nostre aziende di poter essere immediatamente produttive e creare reddito per sé e per il Paese.
Tutto ciò, senza considerare l’ultimo intervento ministeriale che, come noto, ha fissato il prezzo di vendita delle mascherine chirurgiche a 0,50 centesimi di euro, quando oramai le aziende avevano già riconvertito i propri impianti e profuso importanti investimenti in tal senso, assumendo costi ben superiori al prezzo invece imposto. Tale intervento, come chiarito da Gianfranco Di Natale, direttore generale per gli affari istituzionali di Confindustria moda, non ha tenuto nella debita considerazione la circostanza che il costo di fabbricazione delle mascherine prodotte in Italia varia in media dai 45 ai 60 centesimi, con impianti, specie per le aziende riconvertite, che non possono garantire i numeri delle aziende straniere (cinesi in primis), andando anche in questo caso ad avvantaggiare le imprese straniere, con ogni conseguenza anche in relazione alla qualità dei prodotti importati (caso Pivetti tra tutti).
Sino ad arrivare al paradosso odierno della carenza sul mercato di mascherine, in quanto le aziende italiane hanno rallentato la produzione e le aziende straniere esportano in altri paesi traendone maggiori ricavi.
Veniamo ora alla “ripartenza”: quali le criticità dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro?
La cosìddetta «Fase2» di riavvio graduale delle attività, come sappiamo, ha imposto la predisposizione e adozione di adeguate misure finalizzate alla ripresa efficace della vita delle aziende italiane, con una serie di obblighi e raccomandazioni che spesso disincentivano, soprattutto i piccoli imprenditori, al riavvio delle attività produttive e commerciali. Mai come in questo momento l’avvocato giuslavorista deve avere la capacità di trovare la soluzione concreta “sartoriale” per le aziende, dove, con la ripresa delle attività, convivono i timori del contagio da parte dei lavoratori, con il peso delle responsabilità (anche di carattere penale) che incombe ancora più gravoso sul datore di lavoro, che deve cercare di riavviare la propria attività in un difficile equilibrio (o disequilibio) normativo ed economico. E così, ad esempio, poiché il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 si è limitato a raccomandare alcune misure in tema di sicurezza e prevenzione e del perché doverlo fare, in collaborazione con Maurizio Bortolotto, dello studio penalista Gebbia Bortolotto e associati, abbiamo ritenuto utile predisporre un’informativa sull’analisi di impatto del «Protocollo» del 24 aprile 2020 e dei DPCM per le aziende italiane in tema di organizzazione del lavoro, sicurezza sul lavoro, prevenzione, tutele e responsabilità, privacy e modello organizzativo ex dlgs 231/2001, che valutasse sia gli aspetti giuslavoristici, sia gli aspetti penalistici (il documento è consultabile sul sito del mio studio: www.studiolegaleboffoli.it), al fine di chiarire quali misure sarebbe opportuno adottare in linea generale a garanzia e tutela dei lavoratori e delle responsabilità che incombono sul datore. È chiaro che tali indicazioni di portata generale vengono poi rielaborate per ogni specifica realtà e dimensione aziendale. Ferie forzate, smart working, cassa integrazione sono divenuti oramai strumenti “generalizzati” della nuova realtà emergenziale, che devono coniugarsi con tutti gli adempimenti imposti in tema di sicurezza sul lavoro, prevenzione, privacy e modello organizzativo in ipotesi di rientro in azienda, stravolgendo paradigmi ormai ritenuti standardizzati.
Con l’emergenza è poi tornato alla ribalta lo smart working.
Anche su tale tema si sono susseguiti una molteplicità di provvedimenti governativi. Sin dal primo D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 con cui era stata disposta l’applicabilità in via automatica della modalità di “lavoro agile” nelle aree considerate a rischio in situazioni di emergenza nazionale o locale e con il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, all’art. 2, in cui veniva stabilito che le modalità di lavoro agile fossero applicabili, allora sino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati; sino poi al DPCM 4 marzo 2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus sull’intero territorio nazionale, raccomandava le modalità di lavoro agile per la durata dello stato di emergenza dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, stabilendo che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza fossero assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito internet Inail; ed ancora l’esortazione contenuta anche nel Dpcm del 26 aprile. È poi soprattutto il Protocollo tra Governo e parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, aggiornato il 24 aprile u.s., a spingere in questa direzione.
Il Dpcm proroga il quadro normativo in vigore dalle prime settimane di esplosione del contagio, con la possibilità per i datori di lavoro privato di ricorrere al lavoro agile senza accordo con il dipendente e assolvendo in modalità telematica e semplificata il compito di informazione in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito internet Inail. Per il settore pubblico, invece, si rinvia all’articolo 87 del decreto legge 18/2020 in base al quale lo smart working è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Dunque, nel comparto pubblico il lavoro da remoto è lo standard, più che un’opzione: nel corso della conversione in legge del Dl Cura Italia, è stato introdotto l’articolo 87 bis in base al quale può essere aumentato del 50% il valore delle convenzioni quadro Consip per la fornitura di personal computer e tablet da fornire ai dipendenti. Per il comparto privato, confermata la possibilità di ricorrere al lavoro agile senza accordo tra le parti, pur nel rispetto di tutte le altre disposizioni della legge 81/2017 che regola questa modalità lavorativa, è il protocollo a stabilire che il lavoro a distanza «continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione».
Quali le criticità per i tanti che però non avevano pronto un piano?
Nessun provvedimento aveva considerato che quello dello smart working è un concetto in realtà non familiare a tutte le aziende italiane, quantomeno al momento del verificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. L’emergenza ha accelerato e quasi imposto, laddove possibile in base alla tipologia dell’attività assegnata al dipendente, il ricorso allo smart working, che è stato uno dei temi senz’altro centrali delle richieste provenienti dalle società che assistiamo. Le società che avevano già utilizzato lo smart working hanno richiesto di essere rassicurate sulla intervenuta non necessità di dover effettuare accordi sindacali, mentre quelle che non lo avevano ancora adottato hanno dovuto iniziare a sperimentare il lavoro agile in una situazione di emergenza che li ha colti impreparati, costringendole all’immediato aggiornamento di programmi, procedure e regolamenti. Nonostante l’emergenza Covid19 e gli strumenti tecnologici che hanno certamente agevolato la diffusione dello smart working, gli uffici non pare in ogni caso siano destinati a sparire. In ogni caso, lavorare da remoto è stata per molti una necessità se non addirittura un obbligo. Consideriamo, infatti, la posizione delle donne. È stato ritenuto che l’impatto sull’economia delle misure adottate per contrastare l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus produrrà un ulteriore aumento del gender gap nel paese, non essendo stata l’occupazione femminile adeguatamente e sufficientemente sostenute dal Governo e Parlamento. L’art.96 del “Decreto Rilancio”, nel testo approvato il 13 maggio 2020, prevede il “diritto allo smart working”. Si statuisce, infatti, che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 abbiano il diritto a svolgere la prestazione di lavoro ricorrendo allo smart working, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Altra condizione posta per il “diritto allo smart working” dalla citata disposizione è che “non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore”.
Verrebbe quindi da chiedersi cosa succeda a quelle donne che non svolgano attività che possa essere espletata da remoto e, comunque, come sia conciliabile il lavoro in smart working con l’assistenza di molte lavoratrici madri ai propri figli che si trovano a casa a fronte della chiusura di scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie superiori impegnati, anche nelle lezioni con modalità a distanza su piattaforme informatiche. Contestualmente, in Senato è stata approvata la mozione per la parità di genere: 17 punti a sostegno delle donne lavoratrici con l’intento di ribadire che una prospettiva di genere deve entrare nella prassi di ogni norma in modo che gli ostacoli che caratterizzano il percorso delle donne siano finalmente rimossi. Non resta che auspicarsi un intervento normativo che costituisca una vera opportunità di tutela e cambiamento sociale. D’altronde è proprio dalle crisi che possono nascere nuove opportunità di miglioramento.
Passiamo ora alle relazioni industriali: possiamo parlare di una nuova stagione?
Avendo l’emergenza epidemiologica impattato su temi centrali della tutela della salute, della sicurezza dell’ambiente di lavoro e prevenzione, è evidente che abbia rivestito e rivestirà rilevante importanza un proficuo dialogo tra aziende e sindacati, che trova concreta attuazione nelle imprese più strutturate, dotate di rappresentanze sindacali. Ricordiamo che il 24 Aprile 2020 era stato condiviso proprio tra Governo e le varie organizzazioni di rappresentanza datoriali, ad esempio Confindustria, e sindacali come Cgil, Cisl e Uil l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del D.P.C.M. 11 marzo 2020 che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Va evidenziato anche il ricorso alla firma di accordi sindacali di secondo livello in tema, sin dai primi provvedimenti governativi restrittivi, di collocazione forzate in ferie per concordare tempistiche per lo smaltimento delle ferie pregresse e di quelle dell’anno in corso (cfr Documento della Corte dei Conti del 21.3.2020), anche con adozione di particolari modalità di fruizione. Un ruolo fondamentale nell’individuazione e implementazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro è rivestito non solo dalle imprese, ma anche dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori. Tanto ad esempio interviene nella negoziazione “concertata” tra imprese e Organizzazioni sindacali nella predisposizione di Linee Guida delle misure organizzative e di sicurezza in vista della ripresa dell’attività produttiva. Consideriamo anche, ad esempio, la partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori e degli RSL nel Comitato aziendale che si occupa dell’attuazione e del controllo sul rispetto del Protocollo e definizione del relativo programma di controlli (Punto13 del Protocollo).
Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro?
È certamente auspicabile per il futuro una cultura della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori improntata alla condivisione e alla collaborazione tra impresa e Organizzazioni sindacali, sia nell’interesse dei lavoratori, che delle imprese e dei datori di lavoro, gravati oltremodo di nuove ed ulteriori responsabilità. Quando finirà la pandemia che certamente ha segnato il 2020 nessuno lo sa. Secondo l’ipotesi ottimistica e auspicata, il virus starebbe perdendo efficacia e, quindi, potrebbe autoeliminarsi; secondo l’ipotesi pessimistica ci vorra’ almeno un anno, e in questo periodo potrebbe esserci un secondo ciclo di diffusione del contagio. In tale contesto di incertezza, alcune aziende si prodigano nell’ottica di continuare a sopravvivere salvaguardando posti di lavoro e confidando in una ripresa economica, altre si trovano a dover pensare a soluzioni più drastiche per la sopravvivenza dell’azienda con ridimensionamenti dell’attività e organizzazione. «Come durante una guerra o una crisi politica, c’è una perdurante e grave incertezza sulla durata e l’intensità dello shock», ha affermato la capoeconomista del Fondo monetario internazionale, Gita Gopinath. Secondo il Fondo monetario internazionale, la contrazione del 9,1% è la ferita che la pandemia di coronavirus lascerà sull’economia italiana nel 2020. Il Mef prevede quest’ anno una caduta del Pil dell’8%. Lo shock avrà un impatto pesante sul mercato del lavoro. Per l’Italia, il Fondo prevede una disoccupazione in aumento dal 10 al 12,7%. Sulla base di indagini Istat, in Italia, l’emergenza sanitaria da Covid 19 e l’adozione delle misure restrittive hanno provocato a marzo, il primo mese di lockdown, un crollo della produzione industriale senza precedenti, sia nel confronto con il mese precedente che su marzo 2019. La stima dell’Istat rivela rispetto a un anno fa una riduzione tendenziale del 29,3% “che è la maggiore della serie storica disponibile (che parte dal 1990), superando i valori registrati nel corso della crisi del 2008-2009“. Confcommercio lancia il grido d’ allarme: se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente, quasi 270 mila imprese rischiano la chiusura definitiva. Una stima definita persino prudenziale perché, oltre agli effetti economici derivanti dalla sospensione delle attività, va considerato anche il rischio dell’azzeramento dei ricavi a causa della mancanza di domanda e dell’elevata incidenza dei costi fissi sui costi di esercizio totali che, per alcune imprese, arriva a sfiorare il 54%. Le micro imprese saranno le più colpite bastando solo una riduzione del 10% dei ricavi per determinarne la cessazione dell’attività, soglia per molti, da tempo superata. Una cosa è certa. In questo quadro di assoluta incertezza, si impone il massimo dello slancio e dell’impegno da parte delle imprese, ma anche dei lavoratori di qualsiasi livello, del top management, delle organizzazioni sindacali e di categoria, per cercare di garantire la fase di ripresa economica con il necessario supporto dei professionisti che con l’impresa collaborano, per poter effettuare analisi attente delle disposizioni non sempre di facile interpretazione, l’attuazione delle stesse con tutti gli adempimenti talvolta obbligati, ma talvolta da dover adottare comunque anche se meramente “raccomandati”. Come tutti sappiamo, la Repubblica «è fondata sul lavoro» (art. 1), da cui discendono diritti e doveri per contribuire al progresso «materiale e spirituale della società» (art. 4 Cost.). Lavorando, la persona esplica della sua personalità sul posto di lavoro, si costruisce e cresce anche in quanto cittadino, per contribuire così al benessere del proprio Paese. Alla persona che presta il lavoro la Repubblica italiana riconosce e garantisce diritti inviolabili, anche e soprattutto nella dimensione lavorativa (art. 2 Cost.). Il lavoro è considerato valore fondativo della Repubblica, nonché status attraverso il quale si realizza la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, co. 2 Cost.). La carta costituzionale riconosce inoltre nel lavoro un «diritto», da un lato, e un «dovere», dall’altro; la Repubblica si impegna, infatti, a promuovere le condizioni di effettività del «diritto al lavoro» (aiutando la produttività delle imprese), che riconosce a tutti i cittadini (art. 4, co. 1, Cost.), ma al contempo, cristallizza il lavoro come un «dovere», di scegliere e svolgere un’attività o una funzione, concorrendo così al progresso materiale e spirituale della società secondo le proprie possibilità (art. 4, 2° co., Cost.). C’è quindi solo da augurarsi una concreta ed effettiva ripresa economica del nostro Paese che consenta a ogni lavoratore di poter espletare la propria attività lavorativa “con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale” (ex art. 2104 c.c.). Solo favorendo il riavvio della produzione delle aziende potrà essere garantita una proficua ripresa economica del nostro Paese, che potrà consentire la conservazione di quei diritti e servizi che una vera democrazia dovrebbe riconoscere e garantire ai propri cittadini.